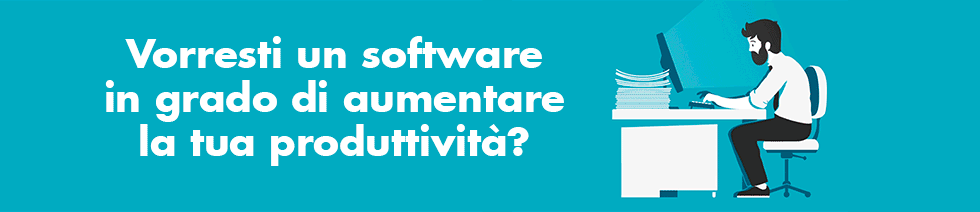Gli eventi di questi mesi ci hanno travolti, è proprio il caso di dirlo, e ci pongono di fronte a molte domande di non facile risposta. Ciò su cui voglio riflettere riguarda il modello di Chiesa che questo virus ha messo in crisi e quello che potrebbe scaturire a seguito di questa pandemia.
Inizio osservando che una delle cose che ci ripetevamo di continuo (penso, ad esempio, all’incontro con i giovani delle scuole superiori della diocesi fatto poco prima della loro chiusura) era la necessità di rivedere il nostro rapporto con i media, soprattutto in ordine all’evangelizzazione. Infatti i ragazzi lo avevano detto chiaramente: per loro non esiste “il mondo reale” e quello “virtuale” ma entrambi sono dal loro percepiti in maniera interscambiabile. La Chiesa, in questo, è parecchio indietro e infatti si è visto quando, a seguito del lockdown, c’è stata l’impossibilità di comunicare, se non attraverso i canali telematici. In tale frangente la consapevolezza che il linguaggio on-line non può essere il medesimo di quello in presenza è sicuramente mancata ai più: si sono fatte moltissime messe, preghiere e incontri in streaming che, tuttavia, deficitavano di linguaggi appropriati e realmente efficaci. Tuttavia il lato positivo è che almeno ci siamo buttati nell’acqua e abbiamo iniziato a nuotare anziché limitarci ad osservare dal bordo della piscina! Per un altro verso non si può non osservare che la Chiesa, per sua natura, è una “santa convocazione” che necessita della presenza fisica delle persone, che la dimensione virtuale non può mai sostituire. Inoltre l’affannosa ricerca di visibilità mediatica ha mancato di considerare che la comunicazione consta di un duplice livello: contenuto e relazione. Se il primo c’è stato ho i miei dubbi sulla reale consistenza della seconda.
Un altro aspetto problematico, legato al fatto di aver detto messa più di due mesi senza il popolo, riguarda il modello di comunità ecclesiale sotteso a questa modalità. Molti hanno obiettato che il digiuno eucaristico avrebbero dovuto farlo anche i preti e i vescovi, perché il loro celebrare in solitudine sarebbe legato ad una visione di Chiesa preconciliare nella quale quello che conta, in fondo, è il culto offerto dal sacerdote, mentre il popolo di Dio (concetto cardine del Concilio Vaticano II) occupa un ruolo marginale. Penso che le cose siano più complesse: innanzitutto mi pare di poter dire che l’idea di comunione ecclesiale va oltre la possibilità fisica della celebrazione comune: pensiamo, ad esempio, al caso limite delle chiese perseguitate dei regimi totalitari, nelle quali sacerdoti debbono spesso celebrare di nascosto e da soli, come anche i fedeli pregare nel chiuso delle proprie case. Questa epidemia può essere senz’altro considerata un caso limite alla medesima stregua: inoltre la celebrazione in solitudine del presbitero non implica necessariamente che egli abbia l’idea di essere auto-sufficiente. Un prete può celebrare da solo portandosi dentro il suo popolo ed avvertendo con chiarezza che sarebbe necessario averlo presente: ugualmente il popolo, pregando con la liturgia domestica, porta con sé, davanti a Dio, anche il proprio sacerdote. Questa io la chiamo comunione. Certo se si pensasse che, in fondo, dir messa senza una comunità in preghiera è indifferente ai fini della celebrazione sarebbe aberrante, come anche lo sarebbe ritenere sufficiente pregare da casa, senza sentire necessario andare in chiesa per l’Eucaristia domenicale.
Certamente tutta questa situazione ha evidenziato una certa povertà di riflessione su questi temi ed una eccessiva polarizzazione di posizioni (messa si, messa no) che hanno tenuto fuori il tema fondamentale: come possiamo oggi, anche a partire da questa situazione, annunciare credibilmente il Vangelo? Perché altrimenti torneremo a fare, più o meno, ciò che facevamo prima, senza chiederci se ciò sia veramente corrispondente ai bisogni e ai linguaggi dell’uomo di oggi. Credo che questa pandemia abbia fatto emergere un bisogno di Dio ed abbia anche evidenziato come le risposte della scienza riguardino il “come” ma non siano in grado fornire un “perché”, cioè offrire uno sfondo di senso: questa è la sfida che ci aspetta, come credenti, e alla quale dobbiamo far fronte.