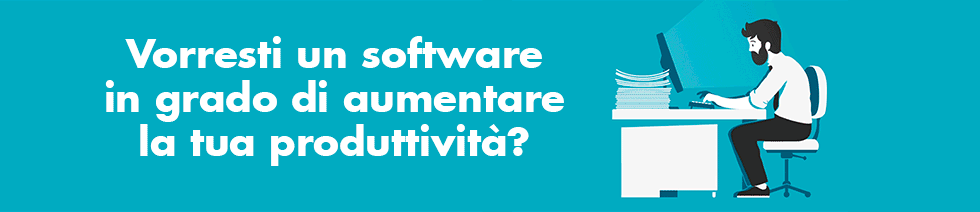E l’Occidente tornò a conoscere la paura. Non il rischio, a cui il progresso della tecnica l’aveva a lungo abituato, una condizione di insicurezza latente, sempre presente ma non presentificata, variabile nell’oggetto, sovente avvertita come distante e inattuale; qualcosa che riguarda sempre gli altri e solo marginalmente noi, vittime incolpevoli di un contagio estraneo. Perché il rischio è conseguenza della modernità, è l’obolo che le è dovuto. Il trionfo dell’uomo occidentale, il successo ininterrotto delle sue conquiste ha relegato al margine periferico il residuo perturbante della modernità. Il vaiolo, il colera, la tubercolosi sono memorie perdute, poco più che immagini del vissuto collettivo. Il rischio attuale – che si tratti di malattie degenerative, di terrorismo, di catastrofi idrogeologiche – per quanto terribile ha perduto il carattere di ineluttabilità. L’Occidente ha vissuto in questa illusione fino a gennaio, poi è iniziato un lento e drammatico risveglio. Così, «ci riscopriamo scarabocchi di una scimmia pittrice».
Relegato inizialmente all’«altro», interpretato secondo la categoria consunta dell’estraneità, il morbo cinese, e poi italiano, ha mostrato quanto sia ridicolo ragionare in termini di stato-nazione, di quanto labili, e di fatto inesistenti, siano i confini tra Stati, tanto celebrati e ottusamente difesi. Non può non colpire l’analogia con l’epidemia di spagnola che esattamente un secolo fa provocò più di dieci milioni di vittime su una popolazione globale di due miliardi; un numero elevatissimo, dovuto più che all’aggressività della malattia alla comorbidità con altri fattori. Ma anche questo è stato dimenticato, relegato, come molto altro, al «non può più accadere». E invece è accaduto, a un mondo non esausto dalla guerra ma assuefatto a se stesso. Le conseguenze sono imprevedibili, sfuggono ai nostri parametri consueti ma ci saranno, hanno già avuto inizio. Mutamenti nel nostro stile di vita, nella conformazione della democrazia, nella comprensione dello spazio pubblico e privato.
Nel venir meno delle strutture abituali di controllo, degli spazi soliti di condivisione ed espressione, qualcosa è emerso con forza, qualcosa che, come il rischio, era ormai dato come un fatto ma che non lo è. La responsabilità. Non che la responsabilità sia il frutto della situazione attuale – le tristi vicende legate alla libera interpretazione delle norme governative lo hanno mostrato. Non la si acquista in seguito a un evento traumatico: l’evento traumatico costituisce piuttosto l’orizzonte del suo manifestarsi. Settori cruciali del nostro sistema hanno retto in virtù dell’abnegazione e della responsabilità del loro personale. Non le leggi, non il timore delle sanzioni ma la vocazione a un compito comunitario, compiuto non per un obiettivo trascendente di gratificazione ma per il dovere, questa voce maestosa e terribile al cui ascolto tendiamo a sottrarci. Eppure l’abbiamo ascoltata. L’hanno ascoltata in primo luogo i medici e gli operatori sanitari, ma l’ha ascoltata anche la Scuola. Non il sistema sanitario o educativo, ma le persone che lo compongono. Quanto sia stata cruciale e complessa la reazione della Scuola pare non occupare un posto di rilievo nelle cronache. Del resto è comprensibile: l’istruzione è data per scontata, una questione la cui risoluzione è lasciata ai suoi operatori. Sin dall’inizio quello della «didattica a distanza» è stato usato come un mantra, come una formula ovvia e già ben collaudata. Ma al di là della narrazione ufficiale, senza le risorse adeguate – e il parallelo con la sanità è d’obbligo –, questa «nuova didattica» era quasi uno slogan privo di applicazione, se non per volontà di alcuni dirigenti e docenti.
La Scuola ha continuato nella sua opera essenziale e silenziosa in questi due mesi, riscoprendosi, inventando nuovi spazi di aggregazione e interazione, trovando nuove vie di inclusione. Ciò è stato possibile, è possibile, grazie allo sforzo degli individui; di chi ha appreso a usare mezzi inusitati, di chi ha riorganizzato la didattica, di chi ha continuato a svolgere il proprio lavoro, con una fatica maggiore – questo bisogna rimarcarlo – rispetto alla situazione abituale, tanto gli studenti quanto gli insegnanti. La situazione emergenziale è diventata la norma. La Scuola ha continuato e continua. I suoi sforzi, collettivi, non sono resi vani dai decreti o dagli opportunismi e dalle resistenze dei singoli. La questione della valutazione, sebbene rilevante, risulta marginale rispetto a ciò che la Scuola è autenticamente: non uno spazio fisico, ma una comunità di intenti. Se la reazione istintuale alla paura è il desiderio di fuga, fisica e psichica, la messa tra parentesi dei nostri obblighi e delle nostre responsabilità, il sentimento di umanità e lo spirito di comunità ci impongono di resistere, ci ingiungono di continuare, ci indicano che nulla è perduto ma tutto è reinventabile e ricostruibile. Gli uomini non temono ciò che ritengono estremamente remoto ma solo ciò che vedono accadere a se stessi o ad altri. La paura non è di per sé vizio né disperazione: al contrario, presuppone la speranza di salvezza; la speranza che permanga ciò che ancora possiede valore. Ed è così che la paura diventa coraggio.